Trovare una terapia per le malattie da prioni è da sempre l’obiettivo del ricercatore dell’Università di Trento che ha contribuito a mettere a punto un metodo di analisi delle proteine che potrebbe avere ricadute importanti anche per altre malattie.
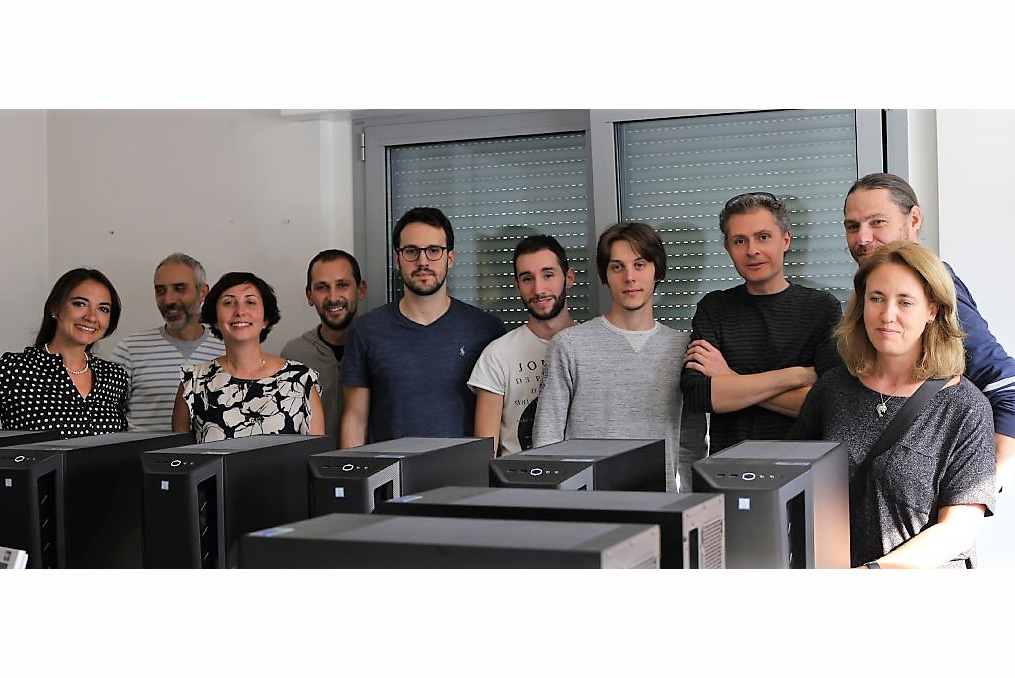
Da più di vent’anni la carriera scientifica di Emiliano Biasini - oggi professore del Dipartimento di biologia cellulare, computazionale e integrata (CIBIO) dell’Università di Trento e ricercatore dell’Istituto Telethon Dulbecco - corre spedita su due binari. Uno è la passione per la proteina prionica, coinvolta nell’insorgenza delle malattie da prioni, rarissime ma gravissime malattie neurodegenerative come la malattia di Creutzfeldt-Jakob, la sindrome di Gertsmann-Straussler e l’insonnia fatale familiare. L’altro è il sostegno da parte di Fondazione Telethon, che lo ha accompagnato dai primi passi nella ricerca, con un dottorato su un progetto finanziato proprio dalla Fondazione nel laboratorio di Roberto Chiesa, al percorso negli Stati Uniti (alla Washington University in St Louis e poi alla Boston University), fino al rientro in Italia. E che con l’ultimo bando del 2020 ha finanziato un suo progetto di ricerca sullo sviluppo di nuovi farmaci in grado di contrastare l’azione neurotossica della proteina prionica. «Per questa proteina è stato amore a prima vista» ricorda il biologo Biasini, che con autoironia non esita a definirsi monomaniacale nei suoi interessi scientifici. «Non smetterò di studiarla fino a quando non vedremo la fine dei nostri sforzi, cioè la cura delle malattie nelle quali è coinvolta. Non posso garantire che ci riusciremo, ma posso garantire che ce la metteremo tutta». E la determinazione che emerge con forza mentre ci racconta del suo percorso, dei suoi progetti, dei suoi risultati, non lascia dubbi sul fatto che sarà davvero così.
Dalla proteina sana al prione tossico
Ma che cos’ha di speciale questa proteina, da riuscire a tenere attanagliato così a lungo l’interesse di un ricercatore? «Intanto, il fatto che è la prima e finora l’unica proteina per la quale sia stata descritta la capacità di comportarsi come un agente infettivo (un virus o un batterio). Una scoperta che nel 1997 è valsa al biochimico e neurologo americano Stanley Prusiner il Premio Nobel per la medicina» spiega Biasini. Che aggiunge: «La proteina è normalmente presente sulla superficie delle cellule del cervello, ma non è ancora chiaro quale sia la sua funzione. Quello che è ormai chiaro è che a seguito di alterazioni strutturali può trasformarsi in una versione tossica chiamata prione in grado di propagarsi come un agente infettivo, inducendo la conversione a catena di altre proteine normali nella versione tossica».
Nuove conoscenze, nuovi possibili approcci terapeutici
Per un certo tempo si è pensato che fosse l’accumulo di prioni nelle cellule nervose a causarne la morte, provocando un processo di neurodegenerazione. Veniva spiegata così l’insorgenza di malattie prioniche come quelle citate o come l’encefalopatia spongiforme bovina, la malattia della mucca pazza che ha colpito l’Europa negli anni Novanta. «Ora sappiamo che questo accumulo non basta e che nel processo di neurodegenerazione è coinvolta anche la forma normale della proteina (e non solo quella alterata) attraverso una funzione fisiologica che non conosciamo», afferma il ricercatore. L’ipotesi è che in seguito al’interazione con la forma alterata, la proteina normale attivi una cascata di segnali biochimici cellulari che inducono il neurone a suicidarsi. «Scoprire che nelle malattie prioniche è coinvolta anche la proteina normale ha rivoluzionato il modo in cui guardiamo ai possibili approcci terapeutici». Se prima l’obiettivo era interrompere la replicazione del prione, ora è diventato ridurre o azzerare la produzione della proteina normale. «Così si impedirebbe non solo la replicazione della forma alterata, ma anche la trasmissione da parte della proteina normale del segnale che porta alla morte dei neuroni» chiarisce Biasini.
Da un fallimento a un innovativo metodo di analisi dello sviluppo delle proteine
A fronte di un obiettivo ben chiaro, però, non lo è altrettanto la strada per raggiungerlo. «Le strategie genetiche più innovative, come l’editing genetico , sono difficili da veicolare nel sistema nervoso centrale e d’altra parte dopo anni di tentativi da parte del mio gruppo, come di altri gruppi di ricerca in tutto il mondo, abbiamo visto che la proteina prionica è praticamente inaccessibile da parte di approcci farmacologici classici. Nessuno, finora, è riuscito a trovare nella sua struttura un punto al quale potrebbe legarsi un potenziale farmaco».
Come spesso accade nella scienza, però, è dai fallimenti che nascono nuove opportunità e dagli incontri casuali che nascono nuove possibilità di svilupparle. L’incontro casuale di Biasini è quello con il collega universitario Pietro Faccioli, fisico teorico. I due si sono incrociati grazie a un corso di laurea che punta a formare esperti di metodi computazionali applicati alla biologia, nel quale insegnano entrambi. Faccioli stava lavorando a una nuova tecnica informatica per studiare il processo che porta le proteine, che nascono come una catenella che si allunga ripiegandosi via via su sé stessa, a raggiungere la loro forma definitiva. «Durante questo processo passano attraverso una serie di forme intermedie transitorie, che nel caso della proteina prionica secondo noi potevano diventare un nuovo bersaglio terapeutico» ricorda Biasini. «È nata così una nuova metodologia di analisi chiamata in sigla PPI-FIT, che in poco tempo ci ha permesso di individuare un intermedio promettente della proteina prionica. Il passo successivo è stato individuare alcune molecole in grado di legarsi a questo intermedio, bloccando lo sviluppo della proteina».
Il nuovo finanziamento di Fondazione Telethon
È a questo punto che si inserisce il nuovo progetto finanziato da Fondazione Telethon e dedicato a sviluppare ulteriormente la più promettente tra queste molecola. «Si tratta di apportare una serie di modifiche chimiche alla sua struttura per migliorarne l’efficacia, riducendo i possibili effetti collaterali e rendendola in grado di raggiungere più facilmente il sistema nervoso centrale. L’effetto di ogni singola modifica andrà testato in colture cellulari fino a quando non otterremo il miglior candidato possibile per passare alla sperimentazione in un modello animale della malattia. E solo se le cose andranno bene si potranno avviare le procedure per la sperimentazione clinica. Ci vorranno anni, ma questa è l’unica strada per poter arrivare, prima o poi, a una terapia».
Dall’Alzheimer al Covid-19: le possibili ricadute della ricerca di Biasini
All’inizio Biasini e il suo gruppo si concentreranno soprattutto su un modello di malattia da prioni familiare, ma uno degli aspetti interessanti di questa ricerca è il notevole potenziale di ricaduta anche in altri ambiti. «Da alcuni anni si sospetta un ruolo della proteina prionica anche in altre malattie neurodegenerative, come la malattia di Alzheimer e quella di Parkinson. L’ipotesi è che in questi casi la proteina faccia da mediatore di tossicità a partire dall’accumulo di altre proteine patologiche, rispettivamente la beta-amiloide e l’alfa-sinucleina. Se avessimo un farmaco efficace nel diminuire i livelli cellulari della proteina prionica potremmo testarlo anche per queste malattie».
E se non bastasse questo a mostrare quanto può essere significativa la ricerca sulle malattie genetiche rare anche per malattie molto più diffuse, Biasini ha subito pronto un esempio che riguarda l’emergenza sanitaria con la quale tutto il mondo si confronta ormai da più di un anno, la pandemia di Covid-19. Biasini è infatti co-fondatore di una startup chiamata Sybilla Biotech che ha l’obiettivo di sfruttare la tecnologia PPI-FIT anche per altre malattie, come cancro e malattie cardiovascolari. «All’inizio dell’emergenza pandemica abbiamo deciso di applicare la nuova tecnologia alla molecola che costituisce la porta d’ingresso del virus Sars-Cov-2 nelle cellule polmonari, il recettore ACE-2. Si tratta di una molecola molto grande, la cui analisi con i mezzi computazionali a nostra disposizione avrebbe richiesto vari mesi. Un limite superato grazie al contributo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, che ci ha messo a disposizione la sua immensa potenza di calcolo permettendoci di trovare 35 molecole potenzialmente in grado di modulare l’attività di ACE-2. Ora ne stiamo sviluppando una in particolare, grazie al contributo di una fondazione americana. A dimostrazione che quando si mette il gettone nel juke box della ricerca non si sa mai con certezza quale canzone uscirà e quali effetti questa potrebbe avere».