Saper leggere il DNA ci aiuta non solo nella diagnosi, ma anche nell’identificazione di colpevoli di reato, persone scomparse o vittime di tragedie: come funziona la genetica forense.

Contiene il codice della vita e non poteva che essere lui a ispirare il nuovo simbolo della Fondazione Telethon, presentato in occasione della campagna La ricerca dona. Dona per la ricerca: è il Dna, che nei giorni scorsi abbiamo imparato a conoscere meglio: che cos’è, dove si trova, cosa fa, quanto misura, quali informazioni contiene, come si legge.
Scegli di stare dalla parte di chi crede nella ricerca e usa anche tu il nostro simbolo!
A proposito della nostra crescente capacità e velocità nel “leggere” il Dna, uno degli ambiti di applicazione più noti, a parte quello diagnostico, è quello giudiziario: che si tratti di cronaca o di fiction, siamo ormai abituati a sentir parlare di “prova del Dna” per identificare il colpevole di un reato. Uno dei casi più noti in cui l’esame del DNA è stato determinante per la soluzione è senza dubbio quello di Yara Gambirasio, su cui di recente è uscito anche un film diretto da Marco Tullio Giordana. La genetica forense è una vera e propria disciplina che, a partire da un campione biologico, permette di identificare l’autore di un reato, accertare dei legami di parentela in caso di dubbio o contestazione, oppure dare un nome a dei resti umani rinvenuti sul luogo di una tragedia o una catastrofe.
Ma di che cosa si tratta e come funziona?
Un po’ di storia: la scoperta delle impronte genetiche
L’idea di sfruttare le conoscenze scientifiche per identificare i colpevoli di reato non è certo cosa nuova: basti pensare che i primi studi sulle impronte digitali, i “disegni” formati dall'alternanza di solchi e creste sui nostri polpastrelli, risalgono alla metà del ‘600.
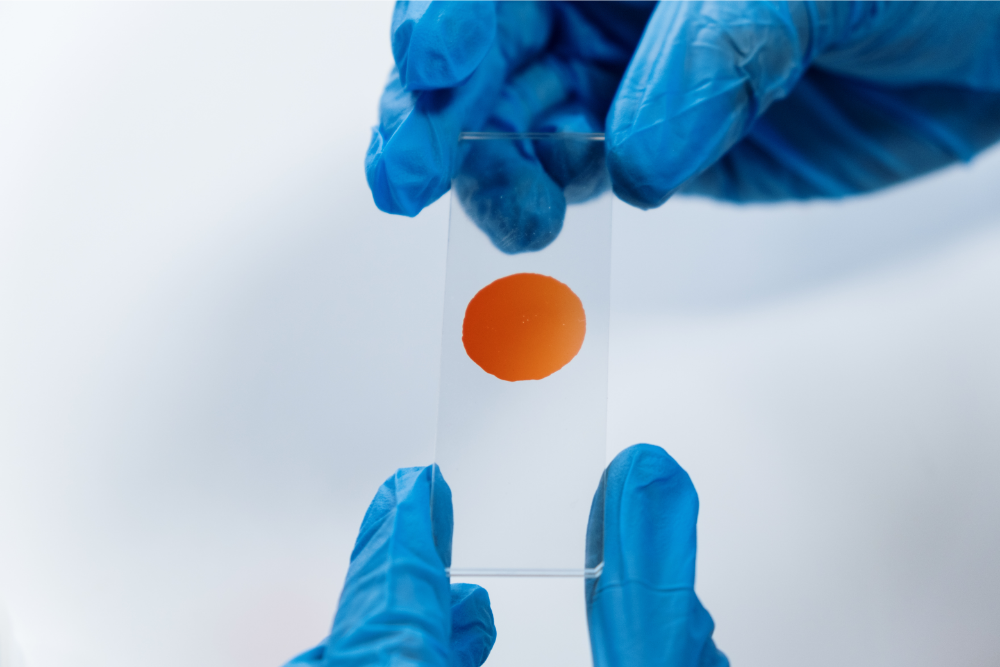
Fino agli anni Ottanta l’unico metodo a disposizione per identificare un individuo a partire da un campione biologico era l’analisi del gruppo sanguigno, che è determinato dalle proteine (antigeni) presenti o meno sulla superficie dei globuli rossi. I gruppi sanguigni sono quattro – A, B, AB oppure 0 in assenza di antigeni – a cui si aggiunge un ulteriore fattore, detto Rh, che può essere positivo o negativo. Le combinazioni possibili sono limitate: il gruppo sanguigno non permette quindi di differenziare in modo univoco un individuo da un altro.
La svolta è arrivata nel 1983 grazie a uno scienziato inglese, Alec John Jeffreys, che ha scoperto che nel nostro patrimonio genetico esistono numerose regioni in cui una breve sequenza di lettere viene ripetuta un certo numero di volte. Si tratta di polimorfismi, cioè regioni non informative e ad alta variabilità all’interno della popolazione, che non contengono geni e che per questo sono state anche definite “DNA spazzatura”.
Jeffreys però ne intuisce l’utilità per ottenere una vera e propria “impronta genetica” della persona, o Dna-fingerprint: analizzando il numero di ripetizioni in un numero sufficiente di regioni del Dna si ottiene infatti una combinazione che è unica dell’individuo.
La prima applicazione in assoluto del fingerprinting genetico è stata nel 1985 in un caso contestato di immigrazione, per confermare l’identità di un ragazzo britannico la cui famiglia era originaria del Ghana. Due anni dopo il metodo ha permesso per la prima volta di risolvere un caso di omicidio, quello di due adolescenti inglesi rapite e uccise nel 1983 e nel 1986 a Narborough, nel Leicestershire: non solo è stato identificato il colpevole, ma è stato anche scagionato un innocente inizialmente sospettato. Nel 1992, il metodo di Jeffreys è stato usato anche per confermare l’identità del nazista Josef Mengele, morto nel 1979, confrontando il Dna ottenuto da un osso del femore del suo scheletro riesumato con quello della sua vedova e di suo figlio.
Se fino al 1987 quello di Jeffreys era l’unico laboratorio in grado di effettuare questo tipo di analisi, presto il metodo si è diffuso in tutto il mondo, perfezionandosi progressivamente. Grazie all’avanzamento tecnologico nel sequenziamento del Dna, anche tempi e costi si sono ridotti drasticamente, così come la quantità di materiale biologico necessaria per effettuare le analisi.
L’importante è il confronto
Un aspetto essenziale da considerare è che un campione di Dna non ci dice nome e cognome della persona a cui appartiene: l’identificazione di un colpevole o di una persona scomparsa avviene sempre per confronto. In altre parole, di fronte a un campione biologico da cui possiamo estrarre il Dna – sangue, sperma, saliva, pelle, ecc – possiamo dire se appartiene a uno specifico individuo soltanto se possiamo confrontarlo con un campione biologico suo o dei suoi familiari.
Per esempio, nell’ambito di una tragedia che rende le vittime non identificabili – si pensi all’incidente aereo di Linate, all’attentato alle Torri Gemelle, ai profughi dispersi nel Mediterraneo – l’identificazione avviene confrontando i resti ritrovati sul luogo del disastro con campioni della persona consegnati dai familiari o con quelli dei familiari stessi.
Un campione di Dna non ci dice nome e cognome della persona a cui appartiene: l’identificazione di un colpevole o di una persona scomparsa avviene sempre per confronto.
Analogamente, nel caso di un omicidio o di un altro tipo di reato, l’analisi del Dna può confermare o viceversa escludere che una traccia biologica ritrovata sulla scena del crimine appartenga a una specifica persona: anche in questo caso, l’identificazione avviene per confronto con un campione biologico prelevato dal sospettato.
Per facilitare l’identificazione degli autori di delitti e delle persone scomparse, anche in collaborazione con la polizia di altri Paesi, in Italia è stata istituita una banca dati del Dna.
Attiva dal 2016, contiene i profili genetici di 35mila reperti biologici ritrovati su scene del crimine, 14mila profili ottenuti dalla popolazione carceraria e circa 7500 persone fermate o arrestate. L’analisi si svolge soltanto su segmenti non codificanti, da cui cioè non siano desumibili informazioni sulle caratteristiche del soggetto analizzato, come per esempio eventuali malattie.
Inoltre, si tratta di una banca dati “anonima”: contiene soltanto dei codici e non nomi e cognomi dei soggetti di cui sono depositati i campioni, che invece si trovano unicamente nella banca dati delle impronte digitali. Per collegare la persona al proprio profilo del Dna è necessario uno speciale ‘token’ (dispositivo per l’autenticazione) che oggi è in dotazione solo a 10 operatori, in tutta Italia.