Storia di Attya, ricercatrice, e del suo viaggio umano e professionale che l’ha portata all’Istituto San Raffaele Telethon di Milano per la terapia genica.
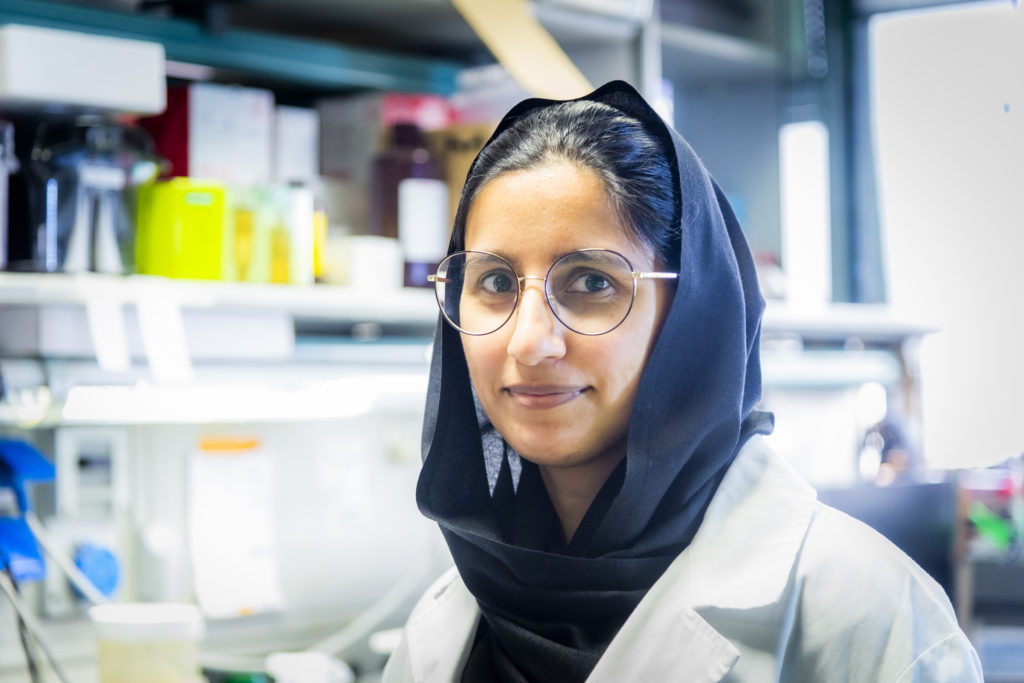
«Non ci sono tanti posti al mondo così validi per studiare la terapia genica applicata alle cellule staminali del sangue»: Parola di Attya Omer, concentrato di determinazione e amore per la scienza, che ha scelto di lavorare all’Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica (SR-Tiget) di Milano e all’Università Vita-Salute San Raffaele e si è appena aggiudicata un prestigioso starting grant dell’European Research Council (ERC): un finanziamento di 1,5 milioni di euro per cinque anni, destinato a giovani ricercatori di talento per avviare un loro progetto indipendente.
Un esempio potente
Attya, classe 1989, è nata a Parigi da genitori pakistani, emigrati in Francia quando erano molto giovani. «Mia madre non è mai andata a scuola, aveva 18 anni quando è arrivata qui a Parigi insieme a mio padre» racconta. «Non avendo potuto ricevere un’istruzione ha sempre voluto che noi figli, siamo in sei, avessimo l’opportunità di studiare. Sono cresciuta in una metropoli europea ma al contempo a stretto contatto con la comunità pakistana: ho visto ragazze cresciute insieme a me smettere di andare a scuola a 16 anni, per il solo fatto che erano donne. La mia famiglia e soprattutto mia madre ci ha spronato ad andare avanti per la nostra strada! Le devo davvero molto, mi ha trasmesso la volontà di non mollare mai, perché ho visto che lei non l’ha fatto, è stata in grado di vivere una vita del tutto piena in un paese straniero anche se quando è arrivata non conosceva neppure una parola di francese!”.
Una studentessa brillante, nonostante i pregiudizi
La carriera scolastica di Attya è stata brillante fin dall’inizio, ma quando è stato il momento di decidere cosa fare all’università ecco che certi pregiudizi hanno fatto capolino. «Nonostante fossi sempre stata tra i primi della classe mi hanno consigliato un percorso di studi tecnico, all’École Nationale Chimie Physique Biologie. Di fronte alla mia motivazione e ai miei ottimi voti, una professoressa mi ha chiesto perché non avessi intrapreso studi di tipo superiore: aveva ragione, infatti dopo la cosiddetta bachelor degree in Biotecnologie, ho conseguito anche il master of science in Neurobiologia presso l’École ratique des Hautes Etudes, istituzione pubblica a carattere scientifico che mira proprio a formare alla pratica della ricerca fondamentale e applicata. Solo qualche anno dopo ho realizzato quanto i pregiudizi riguardo al mio essere una donna dall’aspetto evidentemente non europeo avessero condizionato il mio percorso».
Da Parigi agli Usa
Ma la motivazione di Attya è sempre stata forte: voleva diventare una ricercatrice, così dopo la laurea ha cominciato il dottorato di ricerca all’Université Paris-Sud. «Studiavo la malattia di Huntington, - racconta -una grave malattia genetica del sistema nervoso che è anche uno dei modelli fondamentali per lo studio del cervello umano. Durante il dottorato ho fatto una breve esperienza negli Stati Uniti che mi è piaciuta molto: era un contesto multietnico e stimolante, con dinamiche molto diverse da quelle a cui ero abituata. Così al mio rientro ho deciso che volevo tornarci, ma per farlo dovevo trovare i fondi. Ho provato con il programma Fulbright, che mette a disposizione borse di studio per studiosi, artisti e scienziati. Ho scoperto il bando un giorno prima della scadenza e ho passato tutta la notte a scrivere il progetto, ma ce l’ho fatta!».
Negli Stati Uniti Attya ci è rimasta quasi tre anni, al Whitehead Institute for Biomedical Research di Cambridge, nel Massachusetts. Terminata la borsa Fulbright, infatti, il suo capo le ha proposto di restare. «Non ci ho pensato due volte: oltre al fatto di trovarmi in un contesto scientifico molto stimolante, per me significava anche emanciparmi. Nessuna delle donne della mia famiglia era mai andata all’estero, né aveva mai vissuto da sola: era qualcosa di nuovo che volevo assaporare fino in fondo. Studiavo la microcefalia, una condizione per cui il cervello presenta un volume ridotto, tramite l’impiego di cellule staminali e tecniche di ingegneria genetica. Ero felicissima, soddisfatta e non pensavo di tornare in Europa, almeno non nell’immediato». Ma, come spesso accade, la vita può prendere strade inattese.
Di malattia e d’amore
“Ho ricevuto una diagnosi di tumore del sangue”, racconta. “La malattia per fortuna è stata curata, ma, come tanti altri pazienti, ho fatto esperienza dei pesanti effetti collaterali della chemioterapia. Poiché quello che studiavo era molto interessante, ma con un possibile impatto sui pazienti ancora troppo lontano nel tempo, ho deciso di cambiare ambito di ricerca. Volevo occuparmi di cellule staminali del sangue e fare qualcosa di più vicino ai pazienti, così ho chiesto al mio capo americano quale fosse il posto migliore per applicare le mie competenze di ingegneria genetica alle cellule staminali del sangue in Europa”. Già, perché nel frattempo, durante una breve esperienza in Italia, all’Università di Brescia, Attya aveva conosciuto Farrukh: anche lui di famiglia pakistana, in Italia da quando aveva 12 anni.
«Dopo una relazione a distanza di quasi un anno e mezzo, ci siamo sposati. Il nostro progetto era di trasferirci insieme in Canada - racconta Attya - ma quando ho scoperto di aspettare una bambina ho capito che non volevo crescesse così lontano dalle nostre famiglie. Ecco il perché della mia richiesta relativa all’Europa. Il mio capo non ha avuto dubbi: il posto che faceva per me era senza dubbio l’Istituto San Raffaele Telethon di Milano diretto da Luigi Naldini. Io non credevo alle mie orecchie, era addirittura vicino alla città di mio marito… E a proposito di pregiudizi, ammetto che da sola mai avrei pensato all’Italia».
Dagli Usa a Milano
Il consiglio si rivela quello giusto: il colloquio con Naldini va a buon fine e nell’estate del 2018 si trasferisce definitivamente in Italia, dedicandosi allo studio del comportamento delle cellule staminali del sangue, con l’ambizioso obiettivo di riuscire a sviluppare una strategia di trapianto di queste cellule che permetta di evitare la chemioterapia.
I primi mesi nel nuovo paese non sono facili: quando a ottobre nasce la sua bambina, l’esperienza del parto è piuttosto traumatica: «Mi hanno fatto entrare da sola in sala parto, nessuno parlava inglese né si preoccupava che capissi cosa stesse succedendo. È triste ammetterlo, ma ancora una volta il mio aspetto e il colore della mia pelle hanno influito su come sono stata trattata. All’inizio del 2019, poi, ho iniziato a lavorare all’SR-Tiget: da una parte ero felice di iniziare a lavorare lì, dall’altra non è stato facile conciliare il lavoro con la maternità, nonostante il supporto della famiglia di mio marito. A un certo punto ho avuto un momento di sconforto: una nuova città, una figlia piccola, un nuovo lavoro su un tema nuovo… non è che forse avevo esagerato? Poi ho trovato un mio equilibrio, grazie anche al supporto dei colleghi e del mio capo».
Un equilibrio talmente solido che, dopo la prima, Attya ha avuto altri due figli, nel 2021 e nel 2023. “Certo, i congedi di maternità hanno interrotto temporaneamente il mio coinvolgimento attivo in laboratorio, ma non hanno diminuito il mio impegno di ricerca. Senza contare che a partire dal terzo mese della mia seconda gravidanza è esplosa la pandemia globale di Covid-19: una situazione senza precedenti che mi ha costretta a passare al lavoro a distanza, rendendo necessario un rapido adattamento alla leadership virtuale, visto che ero responsabile della guida di un piccolo sottogruppo composto da uno studente di dottorato e da un tecnico”.
Superare i pregiudizi
Oltre alla ricerca e alla famiglia, però, c’è un altro aspetto che sta particolarmente a cuore ad Attya, ed è quello dell’inclusione delle persone straniere, sul quale ammette che c’è ancora molto su cui lavorare. «Durante il colloquio e i primi mesi di lavoro mi sono presentata indossando il velo, sia per osservare le reazioni delle persone, perché volevo la garanzia di trovarmi in un ambiente inclusivo, sia per stimolare altre donne musulmane a farlo. A volte, infatti, la paura di non essere accettate per il velo (e quindi per quello che si è) diventa un alibi per non uscire dalla propria comunità. Ma dobbiamo tutti ricordare che, nonostante tutto, viviamo in una società multietnica”.
Quanto alla lingua, “in laboratorio tutti parlano in inglese, il problema è quando vai “fuori”: sono convinta che in Istituto servirebbero dei momenti di confronto sui temi del razzismo e, viceversa, dell’integrazione. Da parte mia mi sono sforzata non solo di imparare l’italiano, che sto studiando e che mio marito parla anche in casa con i nostri figli, ma anche di coltivare le relazioni nel posto in cui lavoro. Carriera e famiglia sono entrambi molto importanti e farò del mio meglio per farli crescere qui in Italia». Un punto di vista, quello di Attya, molto prezioso per l’intero Istituto, che si sta impegnando a promuovere un ambiente di lavoro sempre più inclusivo, che possa arricchire il dibattito, non solo scientifico.